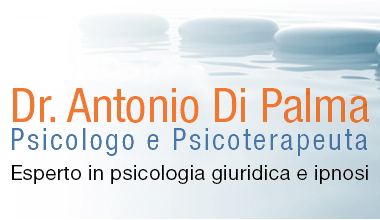Il sogno ha attirato fin dai tempi più remoti l’attenzione dell’uomo per il fascino che emana. C’è sempre stata la tendenza ad attribuire a esso un significato, al punto che le varie religioni hanno sempre visto i sogni come messaggi divini.
Nella tradizione islamica, Maometto riceve la sua investitura di profeta dall’arcargelo Gabrile durante un sogno. Nella bibbia i sogni riportati sono tutti considerati in chiave profetica: il sogno del faraone delle sette vacche grasse e sette vacche interpretato da Giuseppe figlio di Giacobbe. Giuseppe, padre putativo di Gesù, riceve durante i sogni indicazioni su come agire per proteggere la sua famiglia. I sogni, quindi, erano una sorta di messaggi divini, che svelavano, conoscenze altrimenti negate alle normali facoltà umane.
Anche i greci collegavano i sogni al mondo degli esseri soprannaturali. Esistevano presso di loro persino dei templi specifici, ove secondo la credenza popolare, si potevano avere importanti sogni premonitori dopo aver passato ivi la nottata.
La testimonianza più ricca di codesto accostamento tra sogno e divinità ci è offerto da Omero. Nei due poemi omerici incontriamo con abbondanza i sogni inviati dagli dei e dagli spiriti defunti al fine di avvertire i mortali sulle conseguenze dei loro atti, o di renderli edotti su quanto accadeva in un altro luogo.
Anche i massimi filosofi greci si occuparono del sogno dandogli molto rilievo. Al contrario i romani, popolo estremamente pratico (pragmatico), concreto, attaccato alla realtà non erano molto interessati a questo fenomeno. Presso il mondo ebraico un sogno dimenticato o semplicemente trascurato, non interpretato è una sorta d’occasione perduta, di messaggio lasciato cadere, di “lettera non letta”.
Già nell’antichità, quindi, andava maturando la convinzione, la certezza che il sogno, potesse essere sì il portatore di una comunicazione proveniente da un mondo superiore, celeste, divino, ma che potesse del pari riflettere componenti segrete dell’animo umano non sufficientemente e completamente compiute espresse nello stato di veglia.
Nel Medioevo ebbe un sicuro rilievo il sogno di preveggenza. Nel Rinascimento gli intellettuali non si occupano del sogno, mentre la massa continua a crederci e a trarre da essi elementi validi per interpretare il futuro.
L’illuminismo è l’epoca dell’esaltazione delle capacità razionali dell’uomo e della condanna delle pratiche magiche e della superstizione tipica dei secoli precedenti. L’interpretazione del sogno è rifiutata decisamente dagli uomini colti dell’illuminismo, perché è opinione comune che essa alimenti la superstizione del volgo. Ciò permise di dare ai sogni un’impostazione più rigorosa e scientifica.
Pascal contemporaneo di Cartesio si limita a osservare che l’uomo trascorre metà della propria esistenza dormendo e sognando. Il che, conclude il filosofo, deve avere un certo significato, anche se ancora sconosciuto. Con il romanticismo il sogno torna a suscitare un notevole interesse.
Anche se è mancato un lavoro organico e sistematico, prima di Freud sul sogno sono state osservate elementi molto importanti. Per Freud i sogni sono visti come un appagamento, mascherato, di un desiderio rimosso. Jung, completa questa visione del sogno di Freud, vedendoci anche una funzione compensatoria e prospettica. I sogni hanno dei messaggi, che non solo segnalano che qualcosa non va, ma indicano anche la strada per uscire dalla crisi.
Gentile visitatrice/visitatore, se desidera avere maggiori informazioni, o chiedere un supporto, può chiamare al 347.0716419, o cliccare su contatti. Ricevo a Ciampino, via Alessandro Guidoni, Roma, zona Castro Pretorio.